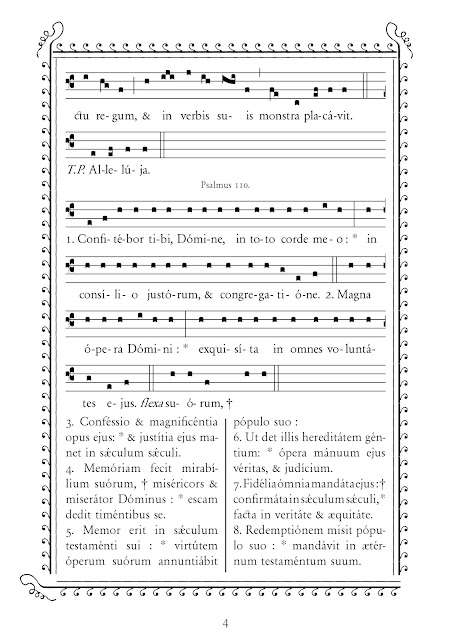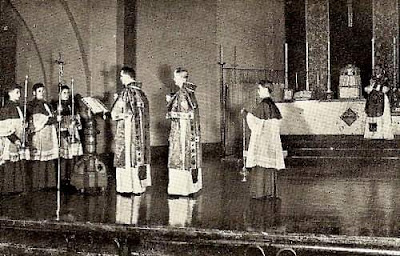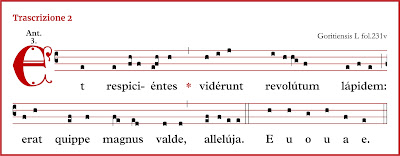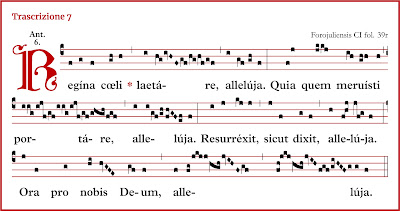Prælegendum
La comune passione per la liturgia, la musica sacra - specie declinate nella dimensione della lex orandi locale - e da ultimo, ma non certo per importanza, una profonda amicizia con Gianluca Gortan Cappellari , hanno determinato i contorni di un progetto volto allo studio e diffusione del patrimonio cultuale facente parte dell'uso liturgico aquileiense tramontato alle soglie del XVII secolo. Questi intenti hanno potuto conoscere una concretezza, in un contesto di ottima sinergia, mercè l'entusiastico accoglimento dell'idea da parte dell'amico e collega giornalista Ivan Bianchi, direttore responsabile di "Nuova Iniziativa Isontina". Il numero 88 (maggio 2023) della Rivista ha ospitato un nostro contributo inteso a ricostruire ed approfondire la celebrazione dei Vesperi pasquali ad Aquileia e nel suo territorio e qui, grazie al consenso della direzione della testata, posso riprendere sul mio blog. L' intenzione è di proseguire in questo filone con l'augurio che questo contributo sia il primo di una lunga serie. Un ringraziamento speciale è dovuto al "Centro per la Conservazione e la Valorizzazione delle Tradizioni Popolari di Borgo San Rocco-ODV", editore del Periodico "Borc San Roc", ultima rivista di studi storici del goriziano, in particolare al suo direttore, l'amico e confratello d'abito teutonico, Vanni Feresin, per il prezioso e fattivo contributo sine qua non.
Trattandosi di un articolo dallo sviluppo articolato, dotato di un ampio corredo di note a piè di pagina, trascrizioni musicali ecc. offro, più sotto ed alla fine del contributo, la possibilità di effettuare un download di una versione integrale in formato *pdf comodamente stampabile, il lettore potrà anche salvare e stampare l'inserto della rivista con l'intera ricostruzione liturgico-musicale del rito trattato.
Francesco G. Tolloi
francesco.tolloi@gmail.com
Effettua il download dell'intero articolo
con la ricostruzione liturgico-musicale
in formato pdf (A5)
Pasqua
e Battesimo
Nella vigenza dell’arcana
disciplina del catecumenato, la notte del Sabato Santo si chiudeva il percorso
formativo di coloro i quali aspiravano ad entrare nella comunità cristiana
mediante la solenne ricezione del Battesimo. Immersi nel Sacro Fonte i neofiti
indossavano una candida veste (alba) che avrebbero mantenuto per otto
giorni (settimana in albis). Anche volendo limitare la chiave di lettura
del Battesimo alla sola dimensione immanente e agli aspetti meramente
antropologici, si evince facilmente la rappresentazione di una morte ed una
conseguente rinascita: per usare categorie paoline si può ben dire che, per
mezzo di quel lavacro, muore l’uomo vecchio e risorge l’uomo nuovo, il
cristiano. Appare perciò pienamente comprensibile che, fin dagli albori della
sua storia, la Chiesa abbia caricato di contenuti battesimali la Pasqua
(passaggio) come si osserva chiaramente in tutte le tradizioni liturgiche
d’oriente ed occidente. Un tanto si
rende particolarmente evidente ancora oggi nei riti della veglia pasquale in
cui una parte consistente ha come fulcro il fonte battesimale. È però
interessante notare come nella lex orandi locale, legata all’uso
liturgico aquileiense, i secondi Vesperi della domenica di Pasqua ,
ed anche quelli dell’Ottava, assumevano particolari connotati, con specifiche allusioni
al Battesimo che appaiono significative e degne d’attenzione.
L’uso
liturgico aquileiense
Abbiamo qui preferito la
locuzione “uso liturgico aquileiense” anziché ricorrere al termine “rito”, ciò
soprattutto perché tali costumanze cultuali della Provincia ecclesiastica di
Aquileia, perdurate sino alle porte del XVII secolo, erano, specie in
prossimità dell’epoca dell’abbandono, come ritiene tra gli altri anche il
liturgista Archdale King, ridotte a una variante del rito romano d’utilizzo
quasi generale .
Nel macrocontesto dato della riforma romano carolingia, essendo patriarca San
Paolino, Aquileia si orientò verso il rito romano. In particolare, all’epoca
dell’autore della Historia langobardorum, si trattò di esercitare l’opzione tra il rito romano e quello
ambrosiano: la complessa faccenda si risolse, affidandola al “giudizio divino”,
con l’adozione del primo. Conseguenza di questa antica decisione è l’esiguità
delle fonti per quello che fu il rito aquileiense propriamente detto, tanto che
oggi sarebbe estremamente complesso, se non impossibile, ricostruire il rito in
uso anteriormente ai fatti qui succintamente richiamati. Tuttavia si possono
riscontrare nei secoli successivi degli usi locali peculiari, documentati dalle
fonti manoscritte ed a stampa, che si estrinsecano durante il cursus
dell’anno liturgico e che appaiono sicuramente meritevoli di indagine, approfondimento
e confronto. Essi furono destinati a perdurare sino al Sinodo provinciale di
Udine del 1596, tenutosi sotto la presidenza del patriarca Francesco Barbaro,
che ne stabilì l’abbandono.
 |
Frontespizio dell'ultima edizione a stampa
del Messale aquileiense (Venezia, 1519) |
Fonti
sul Vespero Pasquale ad Aquileia
Entrando nel merito
dell’argomento specifico di questo scritto, va constatata l’assenza di fonti
risalenti agli albori della Chiesa di Aquileia che permettano di caratterizzare
un eventuale rito pasquale vespertino proprio delle origini: indicazioni in
merito non si riscontrano nemmeno nei pur altrimenti preziosissimi “Sermoni
liturgici” di San Cromazio .
Per gli ultimi secoli dell’uso aquileiense, sono invece diverse ed articolate
le fonti che ci testimoniano la celebrazione e la rilevanza di questo rito in
ambito “patriarchino”. Prima di discuterne le possibili origini ed indicare
delle analogie in altri usi liturgici locali, sarà opportuno descriverne le
caratteristiche e lo svolgimento come potrebbe essere stato celebrato sino al
Sinodo di Udine, confrontandolo specialmente alla forma più strettamente romana
che ci viene attestata dal Breviarium Romanum promulgato nel 1568 da
papa San Pio V (editio princeps) .
Va notato altresì che, nell’area di nostro interesse, non si riscontra una
totale uniformità degli usi e ciò sia sotto il profilo cronologico sia relativamente
alla distribuzione geografica. Nel tentativo di operare una ricostruzione del
rito che sia la più attendibile possibile, è innanzitutto necessario escludere,
almeno ad una prima analisi, tutti i libri liturgici pur in dotazione alla
Chiesa locale ma non di chiara origine aquileiense, tra i quali numerosi codici
di area italiana e soprattutto germanica, giunti in larga parte in queste terre
al seguito dei numerosi Patriarchi d’oltralpe che si sono succeduti sulla
Cattedra di Ermacora .
Tali libri, pur certamente usati e tramandati nel patriarcato, non
costituiscono tuttavia testimonianza di un uso locale, avendo tutt’al più
contribuito allo sviluppo organico dello stesso. Per il rito in esame, tra le
fonti liturgiche manoscritte, ovvero breviari, antifonari e processionali di
certa origine aquileiese, è possibile osservare l’esistenza di quattro varianti
o tradizioni distinte: due più antiche relative a San Daniele del Friuli
(secoli XI-XII) e Cividale (secoli XII-XIII) e due in larga parte successive,
una riguardante il rito per come si svolgeva nella Basilica patriarcale di
Aquileia (secoli XIII-XIV), l’altro per l’uso della Collegiata di Cividale
(secoli XIV-XV) . Le principali differenze saranno
brevemente citate più avanti e sono più dettagliatamente riscontrabili nella
tabella proposta. Al momento basti generalmente osservare come lo sviluppo
cronologico di tali variazioni appaia compatibile con un’evoluzione almeno in
parte locale del rito: le fonti più antiche, infatti, pur con alcune
differenze, presentano maggiori analogie con i primi testimoni latini mentre le
più recenti se ne discostano maggiormente anche con l’introduzione di ulteriori
elementi riscontrabili solo su base locale. In questo contesto, il rito
presente nei libri liturgici redatti per l’utilizzo nella Basilica Patriarcale
di Aquileia, può essere considerata come la matura evoluzione della forma
locale dei Vesperi pasquali, già in parte attestata nel XII secolo ,
e rappresenta la variante più diffusa nei testimoni noti, nonché quella
trasmessa alle edizioni a stampa .
Essa sembra, peraltro, aver costituito la base per l’introduzione di ulteriori
elementi, avvenuta successivamente a Cividale. Inoltre, sono sempre i libri di
Aquileia, redatti per le celebrazioni del Pontifex,
ovvero del Patriarca, che forniscono gran parte dei dettagli cerimoniali,
tramandando le più ricche indicazioni rubricali. Per questi motivi si
considererà tale variante come versione di riferimento sia nella descrizione sia
nella ricostruzione del rito.
La
celebrazione del Vespero di Pasqua
Il clero faceva accesso al coro
processionalmente: precedeva un chierico con il turibolo, altri tre con la
croce astile ed i candelieri, quindi un suddiacono parato con piviale bianco
che portava l’evangeliario, seguiva il resto del clero e dunque l’officiante.
Giunti al luogo deputato il celebrante incensava il testo del santo Vangelo che
poi baciava .
L’ora canonica del Vespero pasquale, di cui possiamo individuare più momenti
distinti ma collegati, veniva aperta dal canto delle nove invocazioni del Kýrie
eléison (a similitudine della Messa) . Nell’uso aquileiense, così come nel
rito romano, il Vespero veniva aperto d’abitudine dall’ invocazione Deus in
adjutórium meum inténde, mutuata dal Salmo 69, ma a Pasqua, nel nostro uso
locale, si aprivano allo stesso modo anche la celebrazione delle altre ore
canoniche, dall’Ora minore di Sesta della domenica pasquale a quella di Terza
del sabato in albis .
Le invocazioni, dal punto di vista musicale, venivano modulate allo stesso modo
riscontrabile nell’Ordinarium I, Lux
et orígo, che l’edizione vaticana dei libri gregoriani riserva al tempo
pasquale .
A questo punto veniva intonata un’antifona dell’VIII modo gregoriano, che ha come
testo l’invocazione Allelúja ripetuta quattro volte. Si segnala
l’esistenza di una variante con Allelúja triplicato, riportata, con
relativa melodia in notazione adiastematica, nel codice San Daniele 4. La stessa antifona era ripetuta dopo il canto
dei salmi 109 (Díxit Dóminus Dómino meo), 110 (Confitébor tibi Dómine
in toto corde meo) e 111 (Beátus vir qui timet Dóminum),
comunemente assegnati, anche nel Breviarium Romanum, ai Vesperi della
domenica ed anche a Pasqua, domenica per antonomasia .
Nel rito romano stricto sensu ciascuno dei salmi era preceduto e seguito
da un’antifona mutuata dalle Lodi del giorno. Mentre nei testimoni locali più
antichi, quali il summenzionato codice sandanielese ed il Breviario di Cividale
XCI, si registra l’uso di completare l’usuale salmodia del Vespero domenicale
con il canto dei salmi 112 (Laudáte pueri Dóminum) e 113 (In éxitu
Israël de Ægýpto), nelle altre fonti, più tardive e diffuse, si registra
l’uso di eseguire l’Hæc dies (Sal. 117, 24), ossia lo stesso brano che
la Messa del giorno assegna come graduale, di cui segue quasi del tutto la
notazione delle edizioni vaticane .
Mentre ad Aquileia il versus è il medesimo utilizzato nella Messa (Confitémini
Dómino, quoniam bonus; Ps. 106, 1),
a Cividale risulta in uso una versione diversa: Confitémini Dómino, fílii
Israël, quia non est álius Deus præter eum: ipse liberávit nos propter
misericórdiam suam; aspícite quæ fecit nobíscum, ut enarrém ómnia mirabília
ejus. Allelúja. (componimento basato su Tob. 13,3-7;
Trascrizione 1) .

Senza
soluzione di continuità veniva quindi cantato l’Allelúja con il versetto
Pascha nostrum (I Corinzi, 5, 7) in tutto simile, per testo e melodia, a
quelli del Messale e Graduale romano
e, parimenti, dei testimoni aquileiensi. Nella circostanza del Vespero si
aggiungeva l’ulteriore versetto, sempre su testo paolino, Epulémur in ázymis
sinceritátis et veritátis (I Corinzi, 5, 8). La rubricazione talvolta
piuttosto meticolosa, in particolare dei codici in uso ad Aquileia ma anche del
Breviarium del Capitolo di Trieste ,
fa trasparire uno spiccato gusto per la drammatizzazione, ottenuta mediante una
serrata alternanza tra i cori che si dividono le singole parti dei brani .
Veniva dunque eseguita l’antiphona ad evangelium, locuzione che indica
che il breve componimento prelude e segue il cantico evangelico di San Luca (Lc
1, 46-55) ossia il Magníficat. Il testo dell’antifona in uso ad
Aquileia, almeno dal XII secolo, «notevole per il ritmo e per la rima» ,
così recita: Post passiónem Dómini, factus est convéntus, quia non est
invéntum corpus in monuménto. Lapis sustínuit perpétuam vitam monuméntum
rédidit cœléstem margarítam. Allelúja. Dal
punto di vista musicale si tratta di un brano del I modo che non tradisce nulla
di particolarmente originale, trattandosi come frequente nella prassi dell’epoca,
del riutilizzo di una melodia antifonaria che potremmo definire di repertorio .
Va qui notato che nei già citati codici della Guarneriana e nell’antico Breviario
cividalese, l’antiphona ad Magníficat è la stessa del rito
romano (Et respiciéntes;
Trascrizione 2),
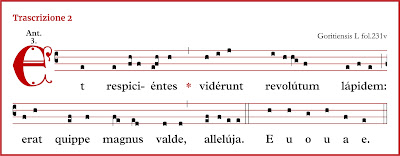
mentre i testimoni, più tardi, di Cividale riportano l’antifona: Et
[/Hæc] dicébant ad ínvicem quis revólvet nobis lápidem, ab hóstio monuménti,
allelúja, allelúja (Trascrizione 3)
.
Quest’ultima
è un’antifona in VIII modo non comune nel repertorio romano, tuttavia attestata
pur con varianti in numerosi codici d’oltralpe ed anche in area padana . Durante
il canto del Magníficat, sebbene le indicazioni rubricali dei codici
tacciano in tal senso, possiamo ritenere che avvenisse l’incensazione
dell’altare, del clero e del popolo secondo l’uso generalmente diffuso. Dopo il
Magníficat e la ripetizione della relativa antifona, l’officiante cantava
l’Orazione che corrisponde alla collecta, di matrice gregoriana,
presente nel Missale Romanum (ed anche in quello aquileiense) nella
Messa del giorno .

È
proprio in questo momento che la celebrazione del Vespero pasquale assumeva dei
toni altamente caratteristici: usualmente la celebrazione delle ore canoniche è
caratterizzata dalla “staticità”, nel comune immaginario si ha il clero assiso
nei suoi stalli che salmodia leggendo dai libri sorretti dal badalone e ci si
limita a spostarsi dal choro – luogo eletto alla celebrazione
dell’Ufficio Divino – per incensare l’altare ai cantici evangelici delle Lodi e
del Vespero, qualora celebrati solennemente. In questa occasione, e per tutta
l’Ottava pasquale, nella nostra tradizione locale si compivano delle
processioni che raggiungevano quei luoghi che evocavano i misteri celebrati nei
giorni precedenti, una sorta di itinerante ripasso, quasi un ideale
pellegrinaggio catechetico per riviverli ed imprimerli indelebilmente nella
memoria. La prima processione si dirigeva alla Croce, simbolo per eccellenza
della redenzione, o all’altare ad essa dedicato, nel caso fosse presente come ad
Aquileia e Cividale .
Ivi si cantava il responsorio Christus resúrgens che i codici locali
tramandano in due versioni diverse, una più lunga, ricca ed ornata in uso a
Cividale (Trascrizione 4), l’altra più stringata ed essenziale.

Il testo, attribuito a re Roberto
II di Francia (Roberto il Pio, 972-1031), appare un rimprovero, se non una vera
e propria invettiva, nei confronti dei crocifissori ai quali viene opposta la
prova della resurrezione del Signore che si ha dalla pietra del sepolcro rovesciata. La già
accennata tendenza ad un approccio quasi teatrale, incluso l’inserzione nel
rito di responsori articolati o perfino azioni drammatiche paraliturgiche non è
certamente esclusivo dell’area aquileiese. Essa piuttosto rientra nel canone poetico-estetico caratterizzante gran
parte dell’arte sacra medievale, e che include un profondo intento didascalico.
Tuttavia, è proprio in area aquileiense, ed in particolar modo a Cividale nel
XIII-XIV secolo, che risulta particolarmente diffusa e sviluppata .
Studi recenti su manoscritti di area padovana inoltre suggeriscono che la
propensione alla teatralità potesse essere, in epoca più remota, un tratto
comune di tutta l’area anticamente legata al Patriarcato .
La tendenza drammaturgica espressa dall’articolazione di questo responsorio va ascritta
ad un contesto caratterizzato dalla frequente inserzione, all’interno dei sacri
riti, di vere e proprie rappresentazioni. Tali drammi si svolgevano tenendo in considerazione
anche l’aspetto spaziale della liturgia, rappresentando in luoghi liturgici specifici
(ad esempio presso il sepulchrum ecc.)
i relativi eventi evangelici. In tale luce, l’approccio drammatico non si
riduce ad un mero intento didascalico, distinguendosi in ciò dalla sacra
rappresentazione, bensì esprime una dimensione sacra, e quindi propriamente
liturgica, riconducibile al principio di exemplum
ed imitatio
ed, in ultima analisi, di riattualizzazione che è cardine fondante la liturgia delle
Chiese apostoliche. Compiuta
l’incensazione - dopo il versetto Dicíte in géntibus [/natiónibus],
allelúja, cui si rispondeva Quia Dóminus regnávit a ligno, allelúja
– l’officiante cantava un’altra orazione (Deus qui ad ætérnam vitam),
ancora una volta di tradizione gregoriana .
A
questo punto si riformava il corteo processionale per dirigersi alla volta del
fonte battesimale che - almeno nelle chiese più importanti, come Aquileia e
Cividale sino al principio del XVII secolo - era distinto dall’edificio
ecclesiastico principale ed anzi costituiva una costruzione autonoma a sé
stante dalle fattezze di una chiesa .
I processionali quattrocenteschi della collegiata cividalese assegnavano a
questo momento l’antifona In die resurrectiónis meæ, dicit Dóminus, allelúja,
congregábo gentes et cólligam regna, ut effúndam super vos áquam mundam,
allelúja (Trascrizione 5).

Come Et dicébant,
anche ques’antifona in VIII modo non trova riscontro nella tradizione liturgica
tridentina ed i testimoni esistenti sono prevalentemente d’oltralpe. L’uso di
questo testo nei Vesperi pasquali è però certamente molto antico e probabilmente
non locale: l’antifona, infatti, è presente, pur con melodia non uguale, nei
Vesperi pasquali di un codice liturgico del XI secolo in uso presso la Basilica
di San Pietro in Vaticano e che è generalmente considerato uno dei principali
testimoni superstiti del cosiddetto “canto romano antico” . È
inoltre interessante notare che tale antifona, con la stessa funzione, si
riscontra anche a Venezia negli usi peculiari della ducale basilica marciana,
perdurati sino ai primi anni del XIX secolo . Presso
il fonte battesimale, ornato ed illuminato a festa, l’antifona Vidi áquam (Ezech.
47, 1-9), del modo VIII - usualmente assegnata al rito dell’aspersione con
l’acqua prima della Messa di Pasqua e delle domeniche del tempo pasquale -
preludeva e faceva seguito al Salmo 112 (Laudáte puéri Dóminum) ed a
Trieste, come attesta il locale Breviarium del XV secolo, si cantava verosimilmente
sotto la stessa antifona, pure il Salmo 113 (In éxitu Israël). Il sacro
fonte veniva incensato e l’officiante cantava il versetto Dómine apud te
fons vitæ, allelúja cui si rispondeva Et in lúmine tuo vidébimus lumen,
allelúja. L’orazione Deus qui diversitátem géntium, il cui testo,
ancora una volta compreso nel Sacramentario gregoriano, si ritrova come collecta
del giovedì dell’ottava pasquale sia nel Missale Romanum sia in quello secundum
consuetudinem almæ Aquileyensis Æcclesiae, chiudeva questa fase del Vespero
di Pasqua .

 |
| Battistero di Aquileia e dettaglio della vasca battesimale. |
Un altro
spostamento avveniva alla volta del “sepolcro”: esso, nella basilica poponiana
di Aquileia, è identificabile con la costruzione rotondeggiante, dell’XI secolo,
presente in principio della navata di sinistra . Va
notato che questo particolare luogo liturgico, anche se chiamato con lo stesso
termine con cui popolarmente si denomina l’“altare della reposizione” -
destinato tradizionalmente alla conservazione dell’Ostia consacrata nella Messa
in Cœna Domini del giovedì santo per la celebrazione della “Messa dei
Presantificati” del giorno successivo (secondo il Missale Romanum) –
conosceva, attorno ad esso, nell’usus aquilejensis, uno sviluppo rituale più ampio e
complesso nel corso delle funzioni del Triduo pasquale.
 |
| Sepolcro della Basilica di Aquileia |
Al Vespero pasquale, presso
il sepolcro, si cantava l’usuale ultimo salmo del Vespero domenicale, ossia il
113 (In éxitu Israël), preceduto e
seguito dall’antifona Veníte et vidéte locum ubi pósitus erat Dóminus,
allelúja, allelúja. Il sepolcro veniva dunque incensato ed il versetto Surréxit
Dóminus de sepúlchro, allelúja – con la relativa risposta Qui pro nobis
pepéndit in ligno, allelúja – precedeva l’orazione Præsta quaésumus omnípotens
Deus che ritroveremo, con analoga posizione e destinazione, negli antichi e
abbandonati usi dell’Urbe .
Fatto ritorno in choro, la funzione si chiudeva con il canto del Benedicámus
Dómino, arricchito dalle invocazioni dell’Allelúja. Il Vespro si
chiudeva quindi con la benedizione del vescovo, se presente, per proseguire, in
ogni caso, con l’officiatura dell’Ora canonica di Compieta.
Secondo
i processionali di Cividale, la conclusione del Vespero pasquale presso la
Collegiata conosceva uno sviluppo di maggiore ampiezza e sarà interessante
notare di come alcuni elementi furono destinati ad una longevità che trascese
di gran lunga l’epoca dell’adozione dei libri liturgici “tridentini”. La
classica formula di congedo dell’officiatura delle Ore canoniche, ossia il Benedicámus
Dómino veniva preceduta da un particolare canto: Submérsus jacet Phárao (Trascrizione 6).

Sebbene le
rubriche dei manoscritti cividalesi indichino il componimento come Prosa,
il Submérsus è più propriamente un tropus alla formula del Benedicámus
Dómino. I tropi erano delle particolari inserzioni testuali che
precedevano, seguivano o persino inframmezzavano i formulari liturgici
ufficiali, che fiorirono in modo piuttosto lussureggiante ed anche
diversificato rispetto agli usi locali nel corso del Medioevo. Nel tentativo di
una restaurazione dell’originaria purezza ed uniformità, i redattori dei libri
liturgici compilati ad mentem dei dettami del Concilio Tridentino li
espunsero. Quello di Cividale, per motivi ignoti e difficilmente indagabili,
scampò de facto alle epurazioni di
Trento per giungere ancora in uso nell’età contemporanea. Questa singolare
sopravvivenza, limitata alla Collegiata di Cividale, forse potrebbe essere ricercata
nella tradizione locale secondo la quale il Submérsus sarebbe stato
importato in Friuli dal patriarca Bertoldo di Andechts (+ 1251). Il prelato
ungherese, signore temporale della Patria del Friuli, era cognato della figlia
di re Andrea, Santa Elisabetta d’Ungheria. Essendo la Santa, celebre per
munificenza e carità, benefattrice del Capitolo di Cividale, volle
espressamente che tale canto fosse adottato dal clero locale: mercé questa tradizione
il brano era detto popolarmente “ongaresco”. Tale ipotesi non convinceva il
Vale, che anzi avanzava l’ipotesi che il
Submérsus potesse essere stato composto da tale frater Antonius
Civitatensis, vissuto nel Quattrocento, autore anche di «[…] altre
produzioni musicali di sapore piuttosto leggero» .
Il canto del Submérsus - detto popolarmente “Fanò”, probabile corruzione
del termine Pharao - avveniva innanzi all’altare di San Donato ove era allestito
il sepolcro: come testimonia ancora monsignor Vale, fino alla sua epoca –
nonostante che per i riti del Missale Romanum servisse solo per le
funzioni del giovedì e venerdì della Settimana Santa – nel tempo pasquale si
mantenevano ancora gli arredi solenni e si lasciava la porticina del
tabernacolo aperta, un lacerto forse interpretabile come allusiva testimonianza
di quelle che erano state le costumanze rituali proprie all’epoca dell’usus
aquileyensis . Questo
brano è inoltre testimone di un’altra peculiarità del repertorio liturgico
musicale cividalese, ovvero l’ampio ricorso al cantus planus binatim, prima forma di sviluppo verso la polifonia,
nella quale due voci di canto piano si muovono autonomamente ed in parallelo,
pur in modo ancora non mensurale .
 |
| Collegiata di Cividale |
Tale
pratica risulta ampiamente diffusa nel medioevo europeo, tuttavia il Submérsus, come alcune altre polifonie
primitive, non trova riscontro al di fuori dalle fonti cividalesi, circostanza
che ne suggerisce un’origine quasi certamente locale . Nel
contesto medievale europeo, sia la pratica compositiva del cantus planus binatim in generale che alcune specifiche composizioni
risultano essere ben più arcaiche dei testimoni pervenutici ed il loro uso,
soprattutto in ambito liturgico, è documentato in molti casi essere stato persistente
nel tempo .
Il Submérsus, tuttavia, utilizzando
la tecnica dello “Stimmtaush”, introdotta nel XII/XIII secolo, certamente non può
essere considerato appartenente al nucleo delle composizioni prepolifoniche più
arcaiche. In accordo con queste considerazioni stilistiche, è forse possibile
ipotizzare una data di composizione corrispondente alla prima metà del XIII
secolo, con un termine ante quem che
si può porre con certezza nel 1264, in corrispondenza alla datazione del testimone
più antico, ovvero il codice Cividale LVIII. È suggestivo osservare come tali
date siano pienamente compatibili con l’ipotesi tradizionale precedentemente menzionata.
Relativamente al perdurare dell’uso, Petrobelli riferisce che esso si mantenne
fino al 1960: si hanno partiture delle voci separate trascritte nel Settecento
ed alcune anche del 1921, una circostanza sicuramente insolita e rara, tanto da
far ritenere che non vi sia stata nessuna composizione polifonica che abbia
avuto un utilizzo così duraturo e prolungato nel tempo .
Il
sacro rito si chiudeva con la formula di congedo Benedicámus Dómino
arricchito dal triplice Allelúja (diversamente dal Breviarium Romanum
che ne prevede due) la cui esecuzione – con una melodia che il Papinutti
definisce «bella e ricca» -
secondo i codici della Collegiata era tradizionalmente affidata ad un bambino,
e dunque col canto dell’antifona Regina
Cœli (Trascrizione 7) .
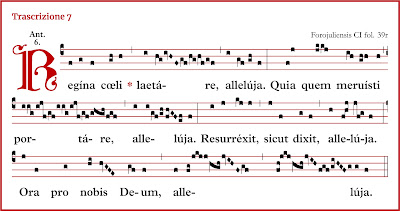
Riguardo le
peculiarità specifiche che si mantennero in Cividale – verosimilmente fino al
1960 ossia fino quando si eseguiva ancora il Submérsus - è ancora il
Vale a ragguagliarcene: alla fine del Vespero si andava processionalmente,
attraverso la navata destra, fino alla porta maggiore del duomo ove si cantava
un’orazione, si raggiungeva il battistero laddove se ne cantava un’altra,
infine, al canto del salmo 112 (Laudáte puéri) si raggiungeva l’altare
di San Donato (adibito a sepolcro) per cantare il tropus. L’Autore, a
margine di questa stringata descrizione dello status quo ai suoi tempi, informa
che, all’epoca, simili usi sussistevano anche in altri luoghi dell’arcidiocesi
di Udine .
Purtroppo, a distanza di quasi centoventi anni dalla testimonianza del Vale,
non è possibile individuare i luoghi precisi cui allude l’Autore, ulteriori
dettagli ritualistici-cerimoniali o particolari brani eseguiti nella
circostanza, lacerti di quella che fu una più ampia lex orandi locale
che merita sempre di essere approfondita e conosciuta.
Considerazioni sulle origini e comunanze con altri
usi liturgici
 |
| Tabella comparativa. Principali versioni dei Vesperi Pasquali nello sviluppo del Rito Romano e dell’Uso Aquileiense secondo le fonti citate nel testo. Per gli Ordines Romani si fa riferimento alla numerazione ed edizione dell’Andrieu, mentre le orazioni sono tratte dal Sacramentario Gregoriano. Per la ricostruzione del rito nella basilica di Aquileia sono stati utilizzati i seguenti codici: Gorizia A e B, UD Arciv. 7, Lubiana Arciv. 18, Trieste Capit. Breviarium Tergestinum; per il rito nella Collegiata di Cividale i codici Cividale XLI, LVII, CI, CII. QOD: Quǽsumus omnípotens Deus; Ts: Breviarium Tergestinum; p: in processione nelle rubriche. Per ulteriori dettagli vedasi il testo. |
L’esistenza
in diverse aree europee di testimoni precedenti i citati codici Aquileiensi,
inclusi anche gli Ordines Romani ,
che già presentavano diversi e sostanziali elementi in comune con la forma
aquileleiense del Vespero pasquale, non depone per un’origine autoctona della
medesima. Essa non rappresenta, o almeno non del tutto, un’esclusività
specifica del territorio, tuttavia va osservato come, diversamente da quanto
avvenne in altre geografiche, nelle terre patriarcali essa si mantenne, ed anzi
si sviluppò, con maggior tenacia nel tempo. Lo svolgimento locale del rito appare
innanzitutto essere una riproposizione ed adattamento ai luoghi nostrani di
quello che fu il Vespero “stazionale” di Pasqua in uso a Roma nel corso del
Medioevo, definito da Amalario come gloriosum officium in Romana Ecclesia
- forse derivato da un antico processo imitativo degli usi gerosolimitani (già
ravvisabile embrionalmente nell’Itinerarium
Ægeriæ )
- che ci viene tramandato soprattutto nelle descrizioni date dagli Ordines
XXX B e L (secondo la numerazione di Michel Andrieu) che datano alla fine
dell’VIII e del X secolo rispettivamente. Pur certamente collocandosi nella
tradizione romana senso lato, va
tuttavia notato il fatto che entrambi questi ordines siano stati redatti oltralpe . Inoltre,
un testimone di poco successivo ma strettamente e certamente romano, quale
l’antifonario della Basilica di San Pietro in Vaticano del XII secolo, presenta
alcune differenze significative con gli Ordines,
tra le quali anche l’ordine delle stationes
.
Complessivamente, si può quindi certamente concludere che a Roma il rito fosse già
ben radicato ma non è possibile escludere che nel suo sviluppo abbiano poi
influito contaminazioni da usi nordici, con elementi simili, peraltro, proprio a
quelli riscontrati ad Aquileia. In mancanza di testimoni patriarcali antichi, è
in ogni caso allo stato impossibile stabilire con certezza quando e da dove
tali usi fossero giunti in ambito aquileiense. Va comunque segnalato come
l’ordine delle stationes nell’ uso di
Aquileia fosse più simile a quello in uso presso San Pietro. D’altra parte,
come significativamente affermava lo studioso salesiano Armando Cuva: «Va
rilevato che la diffusione degli Ordines
favorì lo sviluppo della celebrazione in tutta l’area della liturgia romana.» e
ciò è generalmente sempre vero per quanto attiene l’esportazione delle prassi in
uso nell’Urbe. In aggiunta, appare meritevole di ulteriori indagini una
caratteristica che si riscontra nell’uso aquileiese ma assente nei libri romani
antichi, e cioè la statio ad sepulchrum.
Sulla
scorta del testimone più antico (Ordo
XXXB) descriveremo quindi succintamente le modalità celebrative convenzionalmente
definite romane di questa peculiare officiatura vespertina, che si teneva dalla
domenica di Pasqua fino al sabato in albis, in modo da poter cogliere
facilmente le analogie, ed anche gli adattamenti e le differenze, del costume
locale. Il clero si raccoglieva sotto la Croce trionfale eretta sulla pergula
della navata della basilica di San Giovanni in Laterano, al canto del Kýrie
essi muovevano alla volta dell’abside per prendere posto durante il canto dei
salmi 109 (Díxit Dóminus), 110 (Confítebor tibi Dómine) e 111 (Beátus
vir). Tra il secondo ed il terzo salmo venivano intercalati dei versetti,
dal salmo 92 (Dóminus regnávit), fortemente allusivi al trionfo di
Cristo per mezzo della risurrezione, declamati sia in latino che in greco . Si
cantava dunque il Magníficat ed un’orazione chiudeva questa prima parte
del rito. Ingrossata dalle fila dei neofiti rivestiti della loro candida tunica,
una processione muoveva dietro l’abside dell’arcibasilica, sotto il portico non
più esistente, alla volta del battistero (entrando dalla parte opposta
all’attuale entrata) al canto dell’antifona In die resurrectiónis meæ,
che abbiamo riscontrato essere attestata nell’uso cividalese e marciano. Presso
il battistero si cantava il salmo 112 (Laudáte puéri Dóminum) , dei
versetti in lingua greca, la reiterazione del Magníficat ed un’orazione
chiudevano questa fase dell’officiatura. La processione quindi si riformava per
volgersi, al canto del Vidi aquam,
in direzione del contiguo e non più esistente oratorio della Croce, detto
Sant’Andrea ad Crucem, ove i neofiti avevano ricevuto, nel corso dei
riti vigiliari, la consignatio. È interessante notare come la statio ad Crucem, sia ad Aquileia sia a San Pietro in Vaticano, precedesse
quella ad Fontem. Pur essendo
impossibile trarre conclusioni definitive sull’argomento, va comunque segnalata
la possibile rilevanza, nello sviluppo degli usi locali, della spazialità del
rito, intesa non solo come progettazione dello spazio sacro in funzione del
culto ma anche, in caso di accoglimento di nuove varianti cerimoniali su un
substrato preesistente, come adattamento dello svolgimento rituale alla
disposizione del luogo liturgico .
Alla Croce veniva cantato il salmo 113 (In éxitu Israël) , un
versetto alleluiatico (su testo del salmo 94, Veníte exultémus,
abitualmente impiegato come Invitatorium al Mattutino), l’ulteriore
ripetizione del Magníficat ed un’orazione concludeva il Vespero .
Come annota l’Ordo: «Hæc ratio per totam ebdomadam servabitur usque in
dominica alba» .
Ci
troviamo dunque di fronte a un Vespero “stazionale”, con delle peculiari visite
a luoghi che, come afferma il Righetti, «avevano lo scopo precipuo di
ricondurre i neofiti in pio pellegrinaggio ai luoghi memorandi dove la notte
precedente si era compiuta la loro rigenerazione cristiana ».
Apparirà perciò naturale inquadrare questi particolari riti proprio nel
contesto di “stazionalità”, come accennato di probabile derivazione
gerosolimitana, che caratterizzava in modo importante le celebrazioni romane dell’età
di mezzo. Così come nell’ambito di esse, ed assieme ad esse, ebbe a perdurare, parimenti
assieme ne condivise il declino che si situa nel XIV secolo, segnatamente nel
periodo della “cattività avignonese” che decretò il loro abbandono .
Con il ritorno del papa a Roma - complice anche lo stato di degrado in cui
versavano gli edifici ecclesiastici - le liturgie papali assunsero prevalentemente
una dimensione palatina e dunque una configurazione più “statica” rispetto alla
antica “stazionalità”, di cui poco più rimase che la mera menzione della chiesa
dove si faceva stazione nel Missale
Romanum in particolare nei “tempi forti”. A ciò si aggiunga, per quanto
concerne lo specifico caso dei Vesperi pasquali, che le cappelle non erano
dotate del fonte battesimale, tappa tra le principali di questa particolare
celebrazione. Per tale ordine di concause, nell’uso della curia romana, per
celebrare il Vespero pasquale, ci si accontentò di prendere le cinque antifone
delle Lodi da premettere e far seguire agli ordinari cinque salmi (dal 109 al
113) assegnati al Vespero delle domeniche. In questa nuova fase, le uniche
caratteristiche peculiari dei Vesperi pasquali romani furono l’assenza del Capitulum
(la breve lettura scritturale collocata dopo la salmodia), dell’inno (la cui
assenza è caratteristica del modo arcaico di ordinare l’Ufficio) ed il
versetto, sostituiti dall’Hæc dies, già adoperato come graduale nella
Messa e qui indicato come antifona. In tale forma lo ritroveremo
“cristallizzato” nel Breviarium tridentino .
Tuttavia la forma antica non fu abbandonata del tutto e conobbe delle locali sopravvivenze,
caratterizzate da una marcata diversità degli usi, come nel caso della
giurisdizione ecclesiastica aquileiense, ma anche in diocesi della Francia e
della Renania ed in seno agli usi propri di qualche Ordine religioso . Appare
estremamente interessante che del “Vespero battesimale” si faccia menzione
nell’ Institutio Generalis della Liturgia Horarum – collegata alla
Costituzione Apostolica Laudis Canticum
del 1970 - laddove, al 213 se ne raccomanda la conservazione .
Ciò appare significativo quanto a testimonianza di questa singolare
sopravvivenza ma anche, come riteneva Armando Cuva ,
una solida premessa alla prospettiva di restaurazione e recupero di quella che
il Beato Ildefonso Schuster definì essere «la cerimonia più caratteristica
della festa di Pasqua in Roma» .
Gianluca Gortan Cappellari - Francesco G. Tolloi